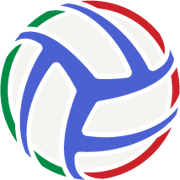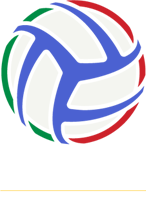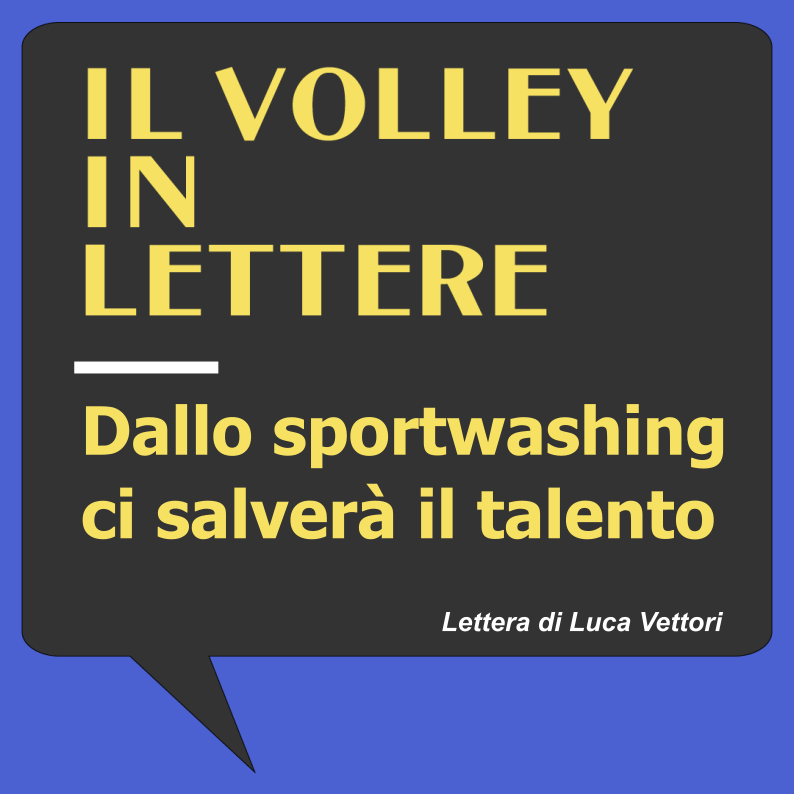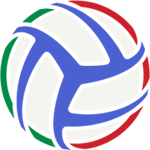Si potrebbero raccontare le recenti elezioni del Comitato Olimpico Internazionale che hanno visto eletta la prima Presidente donna della storia del CIO, Kirsty Coventry, dopo 131 anni in cui si sono alternati presidenti uomini, come una definitiva svolta culturale in atto all'interno del mondo sportivo. Svolta, beninteso, di cui si avrebbe un bisogno inaudito in campo sociale e politico oltre che culturale.
Eppure lo Sport (e non solo), da lungo tempo, ha imparato a depistare l'opinione pubblica celebrando alcuni traguardi specifici ed omettendo altre criticità ben più radicate e profonde. Come si può facilmente ipotizzare il fenomeno in questione è definito sportwashing.
Fino a poco tempo fa sono stato un atleta professionista di pallavolo. Per alcuni anni mi sono trovato in una posizione piuttosto centrale all'interno del panorama sportivo in cui esercitavo. Dopo aver smesso di praticare il mio lavoro, rassegnando piccole grandi dimissioni (a me stesso), tra le prime cose che ho sentito la necessità di fare è stato chiedermi – attraverso interviste e ricerche – cosa fosse lo Sport, quell'ambiente in cui ho lavorato ininterrottamente per quindici anni di vita, nella sua costellazione intera, andando a scavare quindi nella sua parte sommersa e meno visibile.
Lo sport possiede infatti una tendenza: rischia di trasformarsi – sotterraneamente – in una bolla pressoché separata, con un suo proprio ritmo, un suo status, un calendario fitto di prestazioni alienanti, composto da tornei, competizioni e partite senza alcuna interruzione. Atleti ed atlete rischiano di non distinguere nitidamente la natura della propria condizione emotiva, lavorativa ed esistenziale.
Fin dalla più giovane età, ormai, sono rare quelle società sportive che incentivano un'educazione formativa, un'educazione valoriale della persona e del cittadino, che proceda di pari passo con gli impegni agonistici e la carriera sul campo da gioco. Al contrario, le società sportive stabiliscono che, in termini d'investimento al futuro, un atleta dedito, iperspecializzato, devoto alla causa, estraneo o disinteressato a stimoli extrasportivi, abbia una probabilità di successo maggiore rispetto a una persona che pratica sport e che è invece formata nella sua complessità, nella sua interezza, talvolta anche nelle sue intime contraddizioni. Quello adottato dalla gran parte delle società sportive sembra per certi versi il trucco dell’Ulisse omerico: tappare le orecchie dei suoi marinai con l’ordine di remare senza guardarsi intorno. I filosofi della scuola di Francoforte Adorno e Horkheimer individuano proprio nel mito omerico delle Sirene e nella figura di Ulisse il primo seme della modernità capitalistica. I marinai di Ulisse sono archetipi dei lavoratori moderni, che “devono guardare avanti, e lasciare tutto ciò che è lato”. Ulisse, come prototipo di una classe dominante, è il signore “che fa lavorare gli altri” al suo posto, godendo del piacere puramente edonistico del canto delle Sirene senza soccombere ai loro effetti.
Saper disporre e poter esercitare pensiero critico, per un atleta – dalla base al vertice – diviene dunque solo un'eventualità, spesso malvista da chi lo circonda e da chi lo sprona.
C'è una celebre storiella di David Foster Wallace, citata in numerosi contesti, che solleva questo punto.
In un grande oceano, due giovani pesciolini rossi ne incontrano uno più anziano. Quest'ultimo, salutando educatamente gli altri due, gli domanda: "Salve! Allora, oggi com'è l'acqua?" I due pesciolini giovani, senza nemmeno rispondere, si allontanano perplessi. Poco dopo, ancora accigliato, uno dei due pesciolini chiede all'altro: "Ma che cos'è l'acqua?" Questa arcinota storiella mi posiziona. Da una parte perché la consapevolezza dell'acqua in cui si nuota, come si è visto, non si può affatto dare per scontata. Ma anche – soprattutto – perché impone una risposta soggettiva alla domanda "Che cos'è l'acqua in cui io ho nuotato?"
Per poter rispondere vi è la necessità di un pensiero critico allenato quanto (e più di) un corpo, un lavorio costante che sminuzza e ridimensiona la propria postura, la affina e la perfeziona.
Occorre saper riconoscere la propria posizione soggettiva – il proprio privilegio. La mia acqua è stata quella di un atleta bianco, maschio, abile – ed era (ed è) inaccettabilmente diversa da quella in cui si trovano altre categorie che al giorno d'oggi, in diverse parti del mondo tra cui l'Italia, vengono discriminate, marginalizzate se non, talvolta, estromesse: atlete donne, atlet* disabili, atlet* razzializzat*, atlet* omosessuali, atlet* transgender.
Perché, ad esempio, non sono diffusi dati informativi e ricerche specialistiche tra atleti e atlete di alto livello? Perché le istituzioni non incentivano una pedagogia sportiva dalla base al vertice? Perché non esiste una rivendicazione politica e non si costruiscono alleanze generative e trasformative tra le diverse categorie sportive? Numerose iniziative stanno sorgendo, v'è la necessità di prestarvi voce quanto più possibile. Finché non ci chiediamo noi atleti, allenatori, dirigenti, presidenti uomini-bianchi-abili che cos'è l'acqua in cui nuotiamo e non definiamo quello che è il nostro privilegio, noi manteniamo la nostra posizione di sopraffazione, il nostro status dominante. Finché la domanda non diviene bruciante e non diffondiamo capillarmente i semi di una pedagogia sportiva radicale restiamo fissi, imbrigliati, ancorati allo status quo.
Lo sport, per come lo conosciamo oggi, per come ci è stato raccontato nel ventesimo secolo, è uno spazio colonizzato, riempito di contenuti specifici, filtrati, affollato di voci scelte con dovizia per proseguire una condotta. "Lo sport è per tutti", si dice. "Lo sport fa bene". "Lo sport è educativo". "Lo sport insegna la vita attraverso vittoria e sconfitta". Eppure accanto alla retorica pervasiva si rifrangono molte altre storie che sembrano dire il contrario.
Nel podcast "Fuori dai giochi, gli spazi preclusi dello sport", realizzato insieme ad Arianna Scarnecchia per Altreconomia, abbiamo analizzato da diverse angolature quanto il complesso sistema sportivo sia attraversato sul piano decisionale e politico principalmente da alcune categorie di persone, e di come queste categorie si dimostrino sostanzialmente reticenti a un cambio radicale di prospettiva.
Lo sport, al contrario, è uno spazio immobilizzato che ha bisogno di diventare permeabile e mutevole, al passo coi tempi, non più strozzato unicamente da interessi capitalistici.
Riuscire a distinguere la propria posizione di privilegio permette una reazione consapevole, una presa di posizione che favorisca alleanze per immaginare e generare cambiamento.
Immaginazione diviene un termine nevralgico per questo presente storto e distorto. Saper immaginare non è una semplice pratica fine a se stessa ma è anche un fare politico, una capacità sviluppata in milioni di anni, che ha contribuito alla costruzione dell'essere umano.
Scriveva Andrea Zanzotto che i giovani sono "impastati di ignoto e di futuro". Dentro questa pasta si forma il desiderio di meraviglia, di curiosità, la capacità di rabbrividire provando ancora stupore. Da una parte scommettendo su pratiche impensate, reinventando il desiderabile, costruendo possibilità nuove di linguaggio – ovvero quel linguaggio che non appartiene a chi già detiene forza e potere. E dall'altra tenendosi vicini a possibilità urgenti e concrete, proponendo soluzioni verosimili per problematiche imminenti, che generino trasformazioni quanto mai necessarie.
Si prende parte allo spazio sportivo in numerosi modi: si è atleti e atlete, si è allenatrici e allenatori, si è insegnanti di educazione motoria, si è pubblico sugli spalti, si è dirigenti, si è genitori, e si è anche solo semplicemente lettori di media del settore. In ognuno di questi ruoli, chiedersi quale è lo sport auspicabile, lo sport che vorremmo vedere rappresentato e a cui vorremmo appartenere, diviene imprescindibile per una maturazione trasformativa e
plurale. Eppure, come rilevano i recenti dati dell'indagine Ocse, un italiano su tre è analfabeta funzionale. Intervistato ai microfoni di Rai Radio 3 nel programma “Tutta la città ne parla”, Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, sottolineava che sono le implicazioni socio politiche di questo dato a rappresentare la vera urgenza. "Nello smarrimento – nello spaesamento – essere culturalmente non attrezzati rende molti cittadini più permeabili al fatto che attecchiscono stereotipi e pregiudizi che sono ancora molto diffusi e che credevamo invece di aver rimosso. Ma soprattutto rende molti cittadini permeabili a messaggi di tipo demagogico, cioè messaggi che tendono a semplificare la complessità che invece stiamo vivendo e che non siamo attrezzati a decifrare, messaggi quindi che semplificano la realtà e che possono apparire rassicuranti. Nel limbo dell'ignoranza siamo meno attrezzati a decifrare il salto d'epoca, per cui il rischio vero è quello che prosperino messaggi politici distorsivi."
In questo quadro storico la dimensione dell’adolescenza si riversa nella sua complessa criticità. “Bambini felici diventano adolescenti strani che sembrano malati”, scrive Gustavo Pietropolli Charmet nel suo libro Adolescenti misteriosi, “non so nemmeno io di che cosa si tratti, ma penso che abbiano tutti lo stesso dolore: non è la famiglia, non è la loro infanzia, e presumo non sia responsabile del disastro nemmeno internet. […] È la società che li disorienta […] sono abituati e addestrati a competere socialmente su tutti i temi della crescita e su tutti i compiti che bisogna assolvere. La spinta a raggiungere livelli elevati di bellezza e visibilità è intransigente”. Charmet, intervistato da Anna Stefi qui su Doppiozero, asserisce che “i ritirati sociali e le anoressiche sono adolescenti che hanno detto ‘no!’ a un modello di vita e a un universo di valori secondo loro sbagliati e si sono smarcati dai modelli prevalenti: molti di loro hanno esagerato e hanno perso. Se vogliamo che ci siano meno vittime civili bisogna organizzare una tregua e corridoi che consentano ai ragazzi di fare altre scelte, pena la morte o la pazzia”. Ormai trent'anni fa Alexander Langer parlava di una conversione desiderabile come unica via possibile ad un momento di transizione. “La conversione non è solo un termine spirituale, ma è anche un termine produttivo, un termine economico. Significa convertire la nostra economia, la nostra organizzazione sociale verso rapporti di maggiore compatibilità ecologica e di maggiore compatibilità sociale, di minore ingiustizia, di minore divaricazione sociale, di minore distanza tra privilegi da una parte e privazioni dall’altra”. Langer vedeva la necessità di una “rifondazione culturale e sociale di ciò che una società o in una comunità si consideri desiderabile”.
Desiderio mi pare possa essere eletto (in coppia con immaginazione) come secondo termine attorno a cui è possibile costruire questa pedagogia sportiva radicale. Offrendo a ragazzi e ragazze, nelle periferie come nei grandi centri, la convinzione di poter divenire innanzitutto se stessi nella comprensione del sé, avverando il sé, il proprio personale talento. Si dice che una persona talentuosa, nello sport e non solo, sappia prevedere l'accadente in pochi istanti, che riesca a muoversi e ad adattarsi senza una motivazione razionale, creando mondi per smarcarsi dal “vecchio", superandolo.
Dovremmo cominciare, forse, a narrare il talento fuori dalla sfera ipnotica dello sportwashing, rappresentandolo non solo con la parabola dell'adulazione del campione e nell'ottica del mito di successo.
Dovremmo iniziare a definire talento anche quell'attitudine capace di predisporsi ad un immaginario futuro in termini comunitari, paritari, non conflittuali e non competitivi.
Chi ha talento nello sport (e non solo) dovrebbe, oltre che esercitarsi nelle proprie sfide tecniche, fisiche o mentali, applicarsi ad immaginare e desiderare il nuovo imparando a posizionarsi consapevolmente, decolonizzando la propria impronta senza tregua, immettendosi finalmente in azzardate e arrischiate conversioni desiderabili, ben oltre le celebrazioni retoriche e narcisistiche ed ai depistaggi.